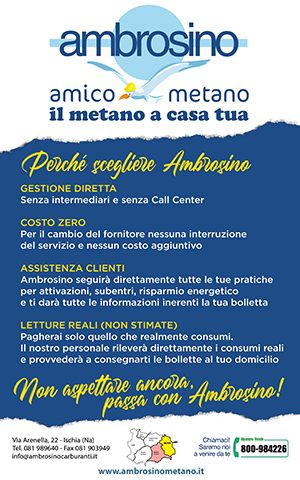La POLPA E L’OSSO di Francesco Rispoli | Noi ci amiamo come papavero e memoria,
noi dormiamo come vino nelle conchiglie,
come il mare nel raggio sanguigno della luna.
(…) È tempo che la pietra accetti di fiorire,
che l’affanno abbia un cuore che batte.
È tempo che sia tempo.
P. Celan, Corona, 1948
Nei nostri dialoghi sono in gioco una memoria “a breve termine” – che ci consente di seguire il filo del discorso – e una “a lungo termine”, che consente di ricordare il significato delle parole in gioco. La memoria si manifesta nelle “pratiche narrative”. Il linguaggio è cosa sociale, è tale se è condiviso, se vi è un senso comune attribuito ai termini.
La tesi che la memoria individuale sia sempre anche memoria collettiva è stata avanzata da Maurice Halbwachs nei libri “Les cadres sociaux de la mémoire”, 1924 e “La mémoire collective”, pubblicato postumo nel 1950. Non si può parlare dell’una senza l’altra. Attraverso il linguaggio inseriamo il ricordo in quadri sociali, come quelli dello spazio e del tempo. Così il ricordo del nostro stesso passato ha a che vedere con una consapevolezza collettiva; i discorsi degli altri contribuiscono alla loro plausibilità e alla loro rilevanza. In tal modo diamo senso alla nostra esperienza cercando di intessere i ricordi in una memoria socialmente condivisa.
Ci sono tre forme di questa consapevolezza collettiva (J. Revel, La memoria e la storia,1998). La prima è la “commemorazione”: cerchiamo occasioni per ricordare ciclicamente il nostro passato e celebrarlo insieme, ritualmente. In secondo luogo non solo tendiamo sempre più a convalidare l’abitudine di conservare le tracce del passato ma ci impegniamo a trasformare in passato molte tracce delle esperienze viventi in una sorta di “patrimonializzazione” generale. Veri e propri “collezionisti della contemporaneità” raccogliamo, classifichiamo, archiviamo tracce del presente, perché rivelino un valore da affidare alla memoria. Vengono infine in primo piano le memorie dal basso. Siamo abituati a pensare a una Storia con la ‘S’ maiuscola e tuttavia estranea e lontana, mentre esistono “tante storie”, con la ‘s’ minuscola, senza le quali non ci sarebbe “storia collettiva”.
Queste tre modalità si possono applicare a determinate collezioni di oggetti e costituiscono un ‘luogo’ della memoria. Un oggetto materiale: un’opera d’arte, un santuario, un monumento, una città. O immateriale: un’idea, una fede, un valore condiviso.